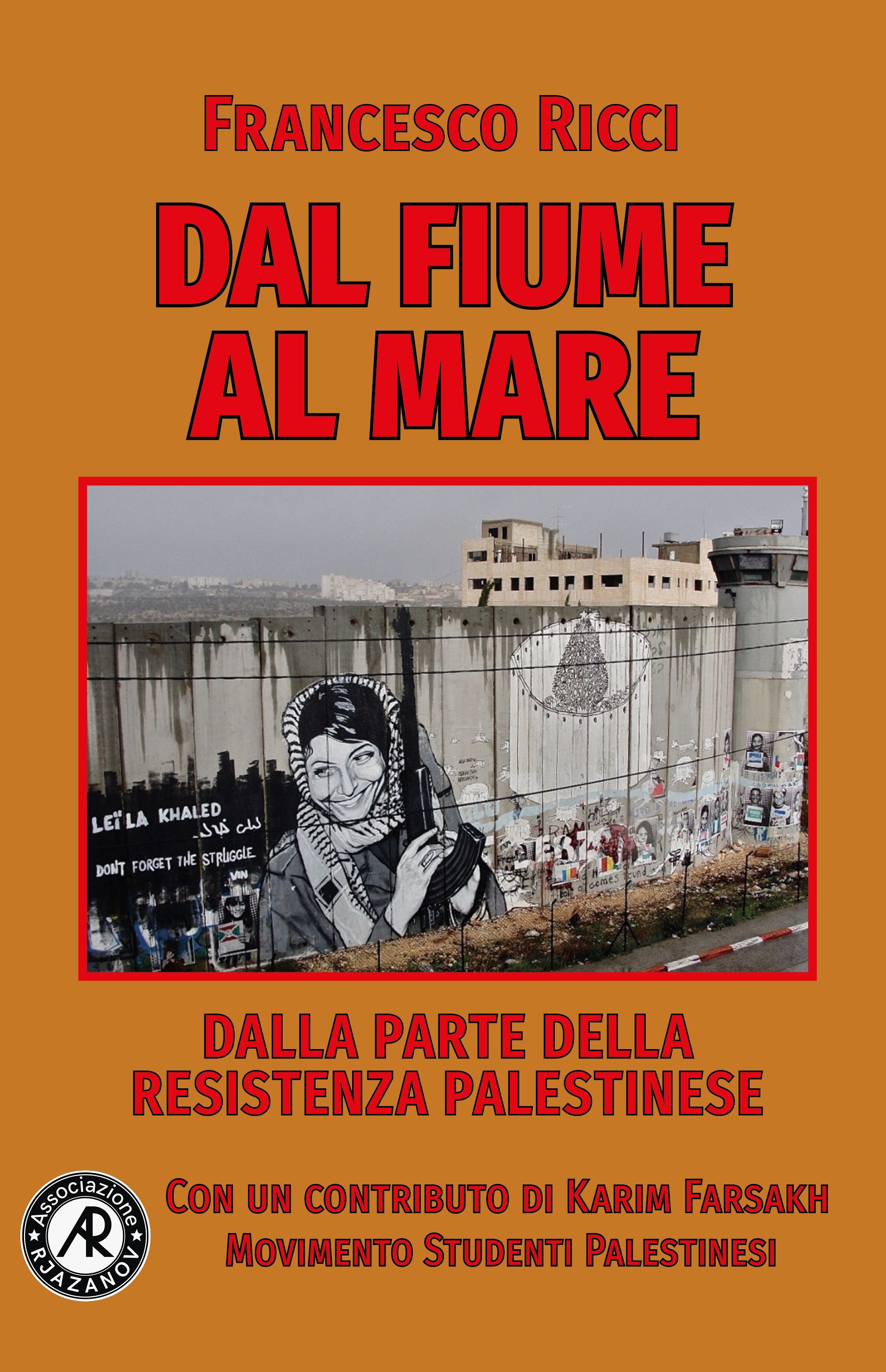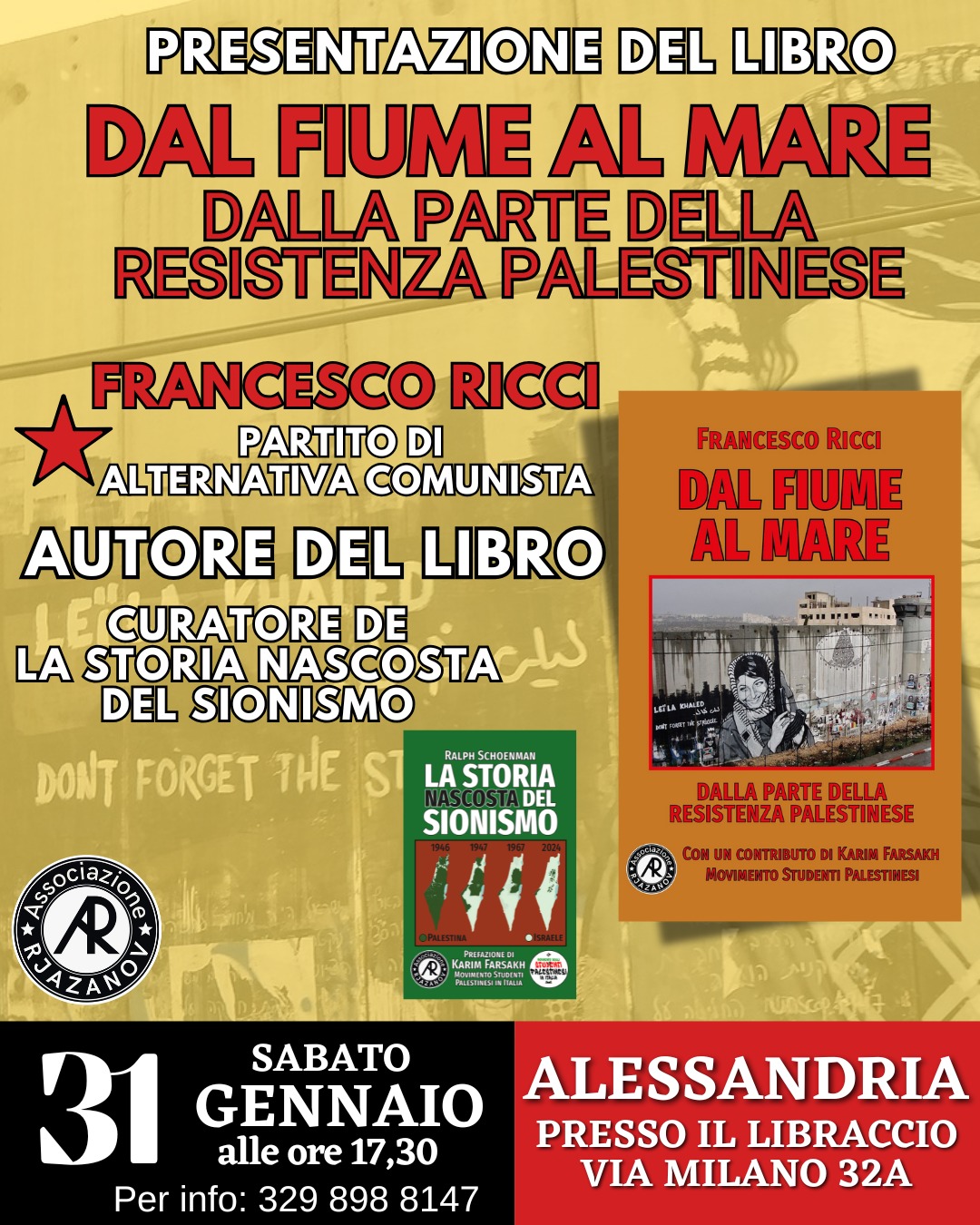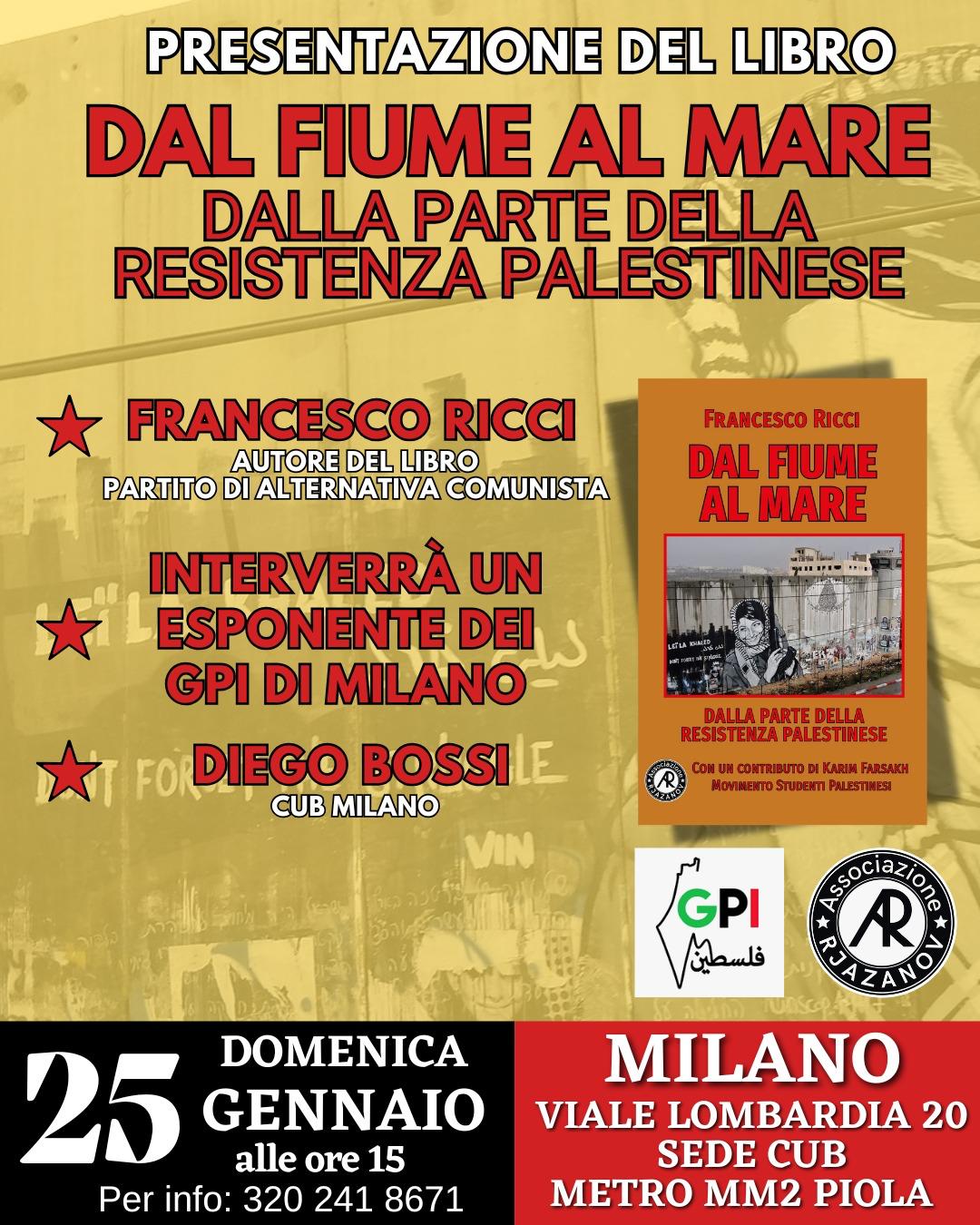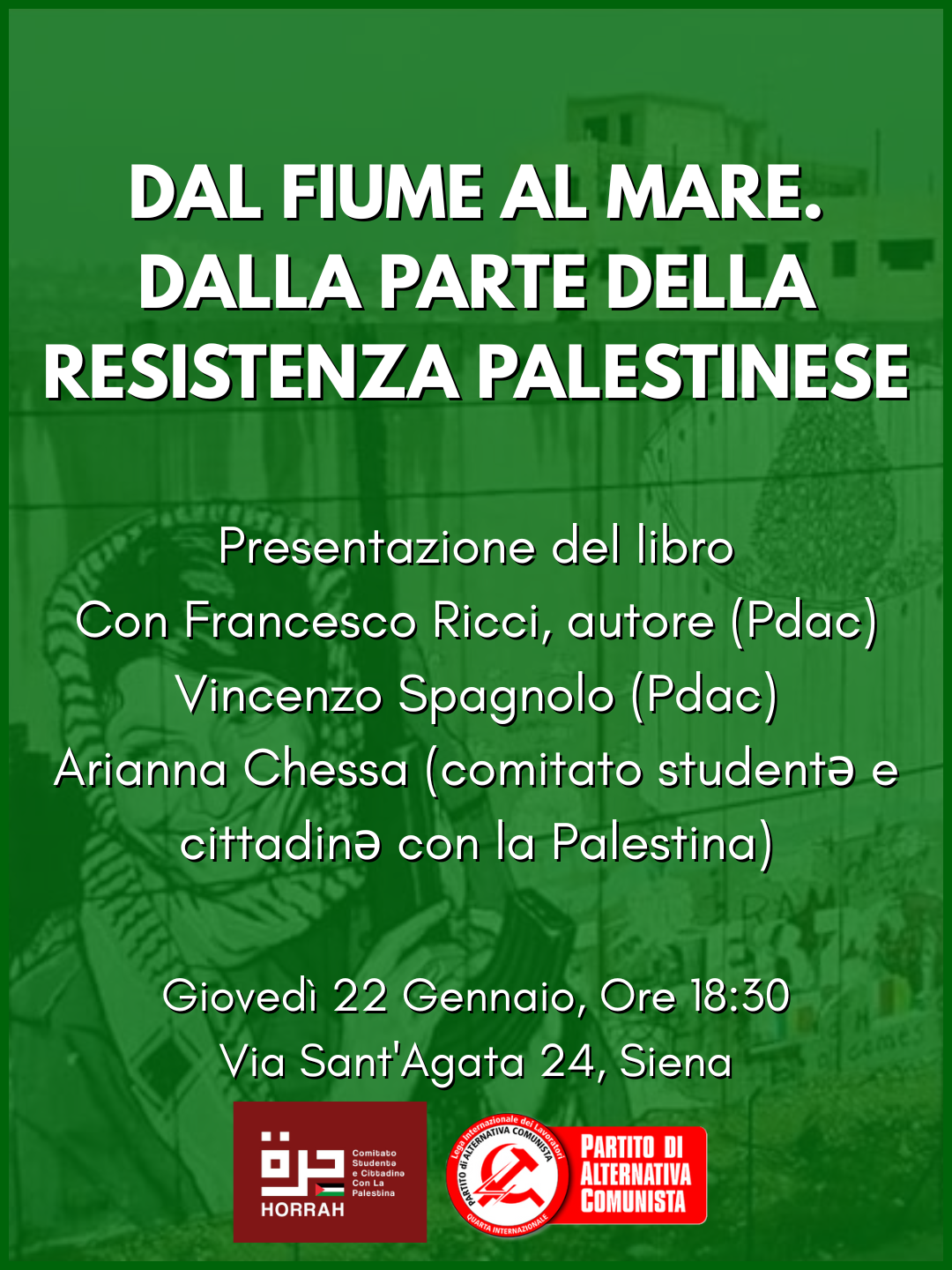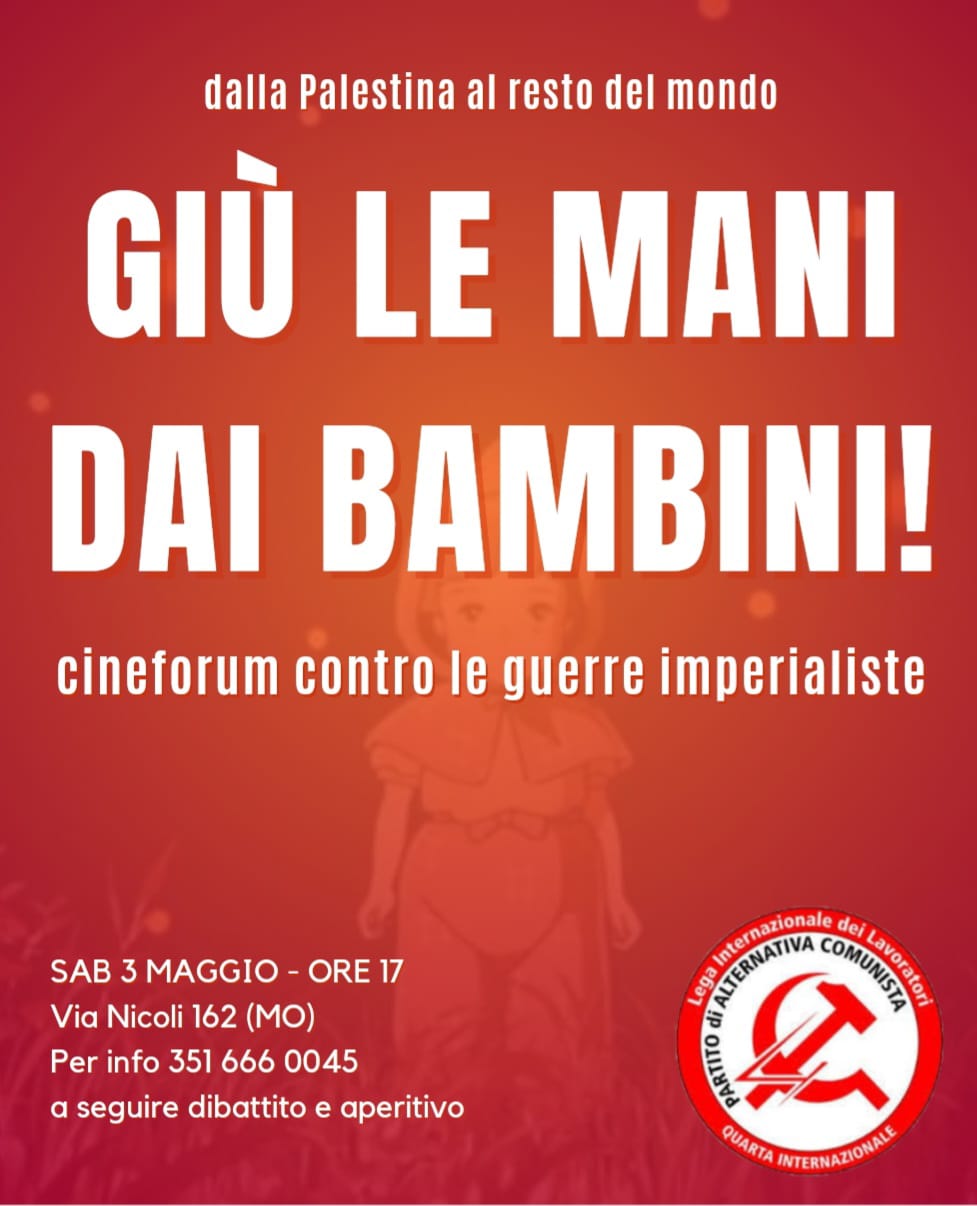Diritto allo studio e alloggi privati
di Roberto Tiberio

Il diritto allo studio in Italia si scontra con una realtà profondamente contraddittoria: l’accesso agli alloggi per studenti fuori sede e pendolari è sempre più difficile, soprattutto per coloro che provengono da famiglie a basso reddito. In un Paese in cui l’università è fortemente centralizzata nelle grandi città, studiare lontano da casa è spesso una necessità, non una scelta. Eppure, trovare una sistemazione accessibile è diventato un privilegio per pochi.
Aumento degli affitti e affari privati
Negli ultimi anni, a fronte di un aumento generalizzato dei canoni d’affitto, lo Stato ha ridotto il proprio ruolo nel garantire un’offerta pubblica adeguata di residenze universitarie, lasciando ampio spazio alla penetrazione del capitale privato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che secondo la vulgata doveva riversare risorse nei beni pubblici, si è rivelato invece un volano per la privatizzazione del diritto allo studio. Dei 960 milioni di euro previsti per la costruzione di 60.000 nuovi posti letto, una larga parte è stata canalizzata verso soggetti privati attraverso modelli di partenariato pubblico-privato, con garanzie minime sull’effettiva accessibilità economica degli alloggi.
In molte città, come Firenze, Bologna, Milano e Roma, il modello dominante è quello dei residence studenteschi di fascia alta, con canoni che superano i 700 euro al mese per una stanza singola. Secondo dati aggiornati al 2025, una stanza singola costa in media 714 euro a Milano, 651 a Bologna, 580 a Roma, 532 a Torino, 511 a Napoli. Si tratta di cifre completamente fuori portata per uno studente il cui Isee familiare è inferiore a 23.000 euro, soglia oltre la quale non si ha nemmeno accesso alle borse di studio.
L’investimento pubblico finisce così per ingrassare operatori privati che agiscono secondo logiche di profitto, mentre la domanda reale – quella che proviene da studenti che non possono permettersi simili costi – resta insoddisfatta. A oggi, su oltre 900.000 studenti fuori sede, solo il 5% ha accesso a un alloggio pubblico: 46.193 posti letto distribuiti in modo fortemente diseguale sul territorio nazionale. I pochi alloggi pubblici esistenti spesso sono inadeguati, sovraffollati, con strutture vetuste e spazi insufficienti. E mentre i fondi pubblici vengono destinati a strutture private di lusso che non rispondono ai criteri di equità sociale, le famiglie a basso reddito si trovano costrette a indebitarsi, a rinunciare agli studi o a vivere in condizioni precarie e insicure.
Un’emergenza permanente
La dimensione strutturale del problema si manifesta nella forma di un’emergenza permanente: ogni anno, decine di migliaia di studenti sono costretti ad abbandonare il percorso universitario o a lavorare in nero per potersi mantenere, alimentando precarietà e sfruttamento. In alcune regioni, come la Toscana, la stessa Ardsu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) ha avviato convenzioni con operatori privati, contribuendo di fatto a consolidare un modello in cui il pubblico funge da garante degli interessi del capitale, non dei bisogni degli studenti.
Le città universitarie si trasformano in laboratori di speculazione edilizia: immobili un tempo destinati ad alloggi per studenti vengono riconvertiti in strutture redditizie per le imprese, mentre il patrimonio pubblico viene svenduto, abbandonato o gestito con logiche aziendali. Questo scenario non è un effetto collaterale, ma un risultato diretto del paradigma capitalista che domina le politiche educative: l’istruzione è sempre meno un diritto e sempre più una merce, connessa al potere d’acquisto e alla rendita urbana. Le università diventano attori immobiliari, trasformando la presenza studentesca in occasione di speculazione, gentrificazione e aumento dei prezzi.
Il profitto privato si appropria di risorse pubbliche, con la complicità delle istituzioni che, dietro la retorica dell’efficienza e della modernizzazione, smantellano progressivamente ogni funzione redistributiva dello Stato. In una prospettiva marxista, è evidente come la crisi abitativa degli studenti rappresenti una manifestazione della contraddizione tra capitale e bisogni sociali: mentre il capitale cerca nuove forme di valorizzazione – in questo caso, tramite il mercato immobiliare legato alla popolazione studentesca – i bisogni collettivi vengono subordinati alla logica dell’accumulazione. Il diritto allo studio diventa così teatro di opportunità per il profitto privato invece di essere volano di crescita culturale.
L’università non è un’istituzione autonoma al servizio dell’emancipazione collettiva, ma un nodo strategico nella catena della valorizzazione del capitale: i campus diventano centri commerciali, gli studentati residenze esclusive, le città universitarie territori in svendita. Ogni euro investito senza controllo del proletariato nei servizi per gli studenti è un euro che contribuisce a rafforzare questo processo.
Un sistema diverso è possibile
Un sistema diverso è possibile, ma non in un'economia capitalista: serve una pianificazione pubblica sotto il controllo dei lavoratori, possibile solo con una rottura decisa con questo sistema socio-economico. Sarebbero necessarie forme di controllo pubblico sugli affitti, piani di edilizia studentesca e vincoli urbanistici per impedire la conversione di immobili pubblici in residenze private di lusso. costruire un piano (inter)nazionale per l’edilizia studentesca pubblica, che miri ad ampliare in modo massiccio l’offerta di alloggi a canone calmierato, riqualificando il patrimonio esistente, recuperando immobili inutilizzati, vincolando l’utilizzo dei fondi pubblici a criteri di accessibilità reale.
È necessario anche introdurre un tetto agli affitti nelle città universitarie, rafforzare il controllo pubblico sugli operatori privati, impedire che le risorse pubbliche continuino a essere drenate verso soggetti che agiscono solo in funzione del profitto.
Occorre una riforma radicale dell’università e delle politiche abitative, che metta al centro il diritto alla città e la giustizia sociale. Il sapere non può essere una merce, né può esserlo lo spazio in cui esso si trasmette. L’istruzione dovrebbe essere un bene comune, non come un servizio da acquistare sul mercato.
Per imporre questo programma, serve una mobilitazione studentesca e sociale che rivendichi il diritto a studiare, abitare, vivere: fuori dalla logica del profitto, contro la mercificazione dell’università, per un futuro in cui il diritto allo studio non sia un’illusione ma una realtà garantita a tutte e tutti.
La lotta per la casa e la lotta per l’istruzione non possono più essere disgiunte: sono due volti dello stesso conflitto, quello tra il capitale e la vita. Le occupazioni studentesche, le proteste contro il caro-affitti, le rivendicazioni di spazi pubblici sono segnali di una generazione che rifiuta di essere strozzata dalla rendita e dall’indebitamento. In gioco non c’è solo la possibilità di studiare, ma la possibilità stessa di esistere dignitosamente. Ogni letto negato è un sapere escluso, ogni stanza invendibile è un diritto sottratto, ogni metro quadro convertito in profitto è un metro sottratto alla collettività.
La risposta deve essere collettiva, organizzata e radicale: non si tratta di chiedere clemenza al mercato, ma di imporre il primato del bisogno sull’interesse, della giustizia sull’accumulazione, della vita sul profitto. La questione degli alloggi non è un dettaglio secondario del diritto allo studio, ma il suo fondamento materiale: senza casa non c’è università, senza accesso non c’è sapere, senza giustizia sociale non c’è futuro.